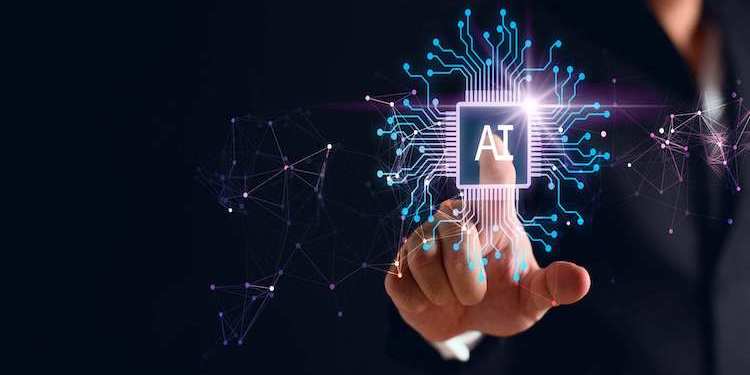Un giorno sono entrata in una carrozza della metropolitana quasi interamente occupata da una classe di ragazzini, che occupavano varie file di sedili. Ben educati, dato che su indicazione dell’insegnante almeno 2 di loro si sono alzati per cedermi il posto. La segnalazione della mia presenza da parte del maestro, era stata necessaria dal momento che tutti gli alunni senza eccezione, maschi e femmine, erano chini sul cellulare. Seduta, li ho osservati per la durata del tragitto: non hanno mai alzato lo sguardo, in silenzio, senza ridere o scherzare, senza contatti con i loro compagni. Una visione perturbante. Qualche minuto prima dell’arrivo a destinazione, l’insegnante li ha avvertiti di riporre lo smartphone. Come un gregge di pecorelle obnubilate, hanno obbedito.
Analogo turbamento quando sono salita su una funicolare panoramica con vista sul Sassolungo, nelle Dolomiti. Il ragazzino al mio fianco, in prima fila di fronte a una visione spettacolare che attira turisti da ogni parte del mondo, non ha mai sollevato lo sguardo dal cellulare. Mi sono voltata sgomenta verso i genitori, dietro di lui. Anche il padre era immerso nella messaggistica del suo smartphone…
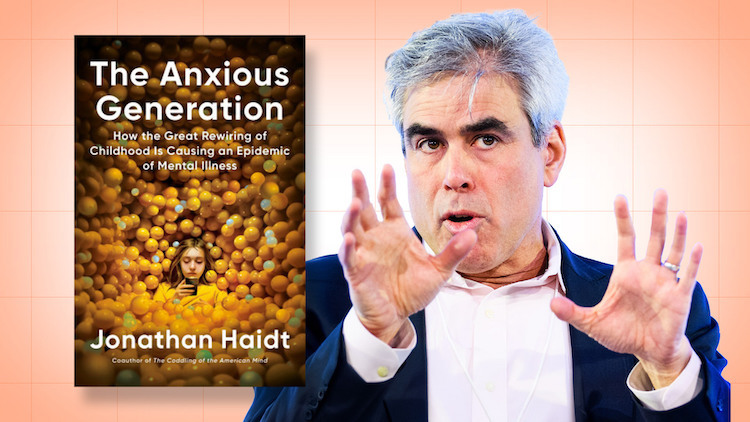
Ecco perché consiglio a tutti i genitori la lettura di La generazione ansiosa dello psicologo statunitense Jonathan Haidt (Rizzoli, 456 pagine, € 22), per illuminarli su come aiutare i loro figli persi dentro i cellulari a comprendere i pericoli a cui sono esposti. E a cosa stanno rinunciando. Questo libro indaga i motivi per cui fra i membri della Generazione Z (nati dopo il 1995) si è verificata, fra il 2010 e il 2015, un’impennata dei casi di ansia, depressione, autolesionismo, incluso il suicidio. Il motivo è che sono i primi ad avere sperimentato quella che l’autore definisce la Grande Riconfigurazione, ovvero hanno vissuto un’infanzia “basata sul telefono invece che sul gioco ”. Il solo cellulare non sarebbe bastato da solo a “riconfigurare ” l’adolescenza. A riuscirci è stato l’avvento del binomio social media–smartphone, che ha raggiunto un’enorme platea di giovani fra il 2012 e il 2013.
Qualche dato è necessario per capire lo sviluppo del fenomeno: dopo la nascita di Facebook nel 2004, nel 2007 è arrivato lo smartphone, nel 2010 è uscito l’iPhone 4: il 1° con una telecamera frontale che ha permesso di scattare foto e video di se stessi da postare sui social. Nel 2010 è nata Instagram, che dopo 2 anni è stata acquistata da Facebook ; e dopo l’introduzione di foto, video e microstorie ha aumentato progressivamente i suoi iscritti da 10 milioni a fine 2011 a 300 milioni nel 2014 (oggi 2 miliardi di persone la usano mensilmente e 3 miliardi utilizzano Facebook, ci sono anche TikTok, YouTube… e i giovani sono iscritti a molti social contemporaneamente). Grazie a questi strumenti, liberi di usare gli smartphone fin dalla preadolescenza, i giovani sono stati risucchiati nel mondo dei social. È ormai noto che le grandi aziende che li gestiscono si ispirano a un modello imprenditoriale orientato alla pubblicità e raccolgono i dati degli utenti (sia adulti, sia ragazzi ) per venderli alle aziende. Allo scopo, hanno studiato e impiegato tecniche per tenere gli utenti incollati allo schermo il più a lungo possibile. Fra gli altri, lo ha segnalato un ex analista di Google, Tristan Harris, che ha svelato come le aziende hanno scientemente sfruttato le vulnerabilità psicologiche dei teenagers per catturare la loro attenzione il più possibile.
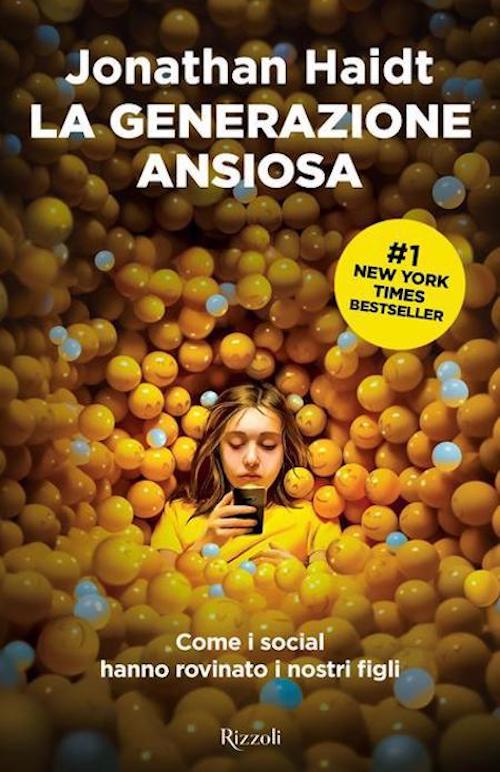
I bambini, spiega Haidt, negli anni in cui il loro cervello si sta ancora modellando hanno bisogno di gioco, di socializzazione nel mondo reale, di contatti fisici con i loro coetanei. Necessitano di esperienze reali e non virtuali, che avvengano in modo sincrono e non differito, sviluppandosi nello stesso luogo fisico e non a distanza. Le loro possibilità di crescita e di sviluppo sano, sono state soffocate negli anni dal 2010 al 2015 quando gran parte di loro ha cominciato a trascorrere sempre più tempo davanti a uno schermo per una serie di attività virtuali – dai videogiochi ai social – o visitando siti pornografici, la maggior parte dei quali non controllano come dovrebbero l’età dei navigatori. Le conseguenze più evidenti, come spiega l’autore, sono state: deprivazione sociale, frammentazione del sonno e dipendenza. E poi ansia e depressione, che secondo gli studi hanno colpito in modo maggiore le ragazze. Mentre infatti i ragazzi sono più orientati all’azione anche nel mondo virtuale, le ragazze cercano sui social soprattutto conferme e accettazione sociale.
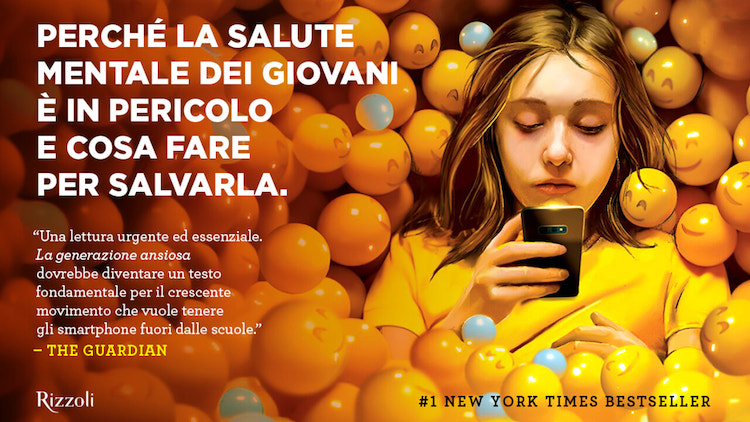
Nei capitoli finali, Haidt invita i genitori, gli insegnanti, le aziende tecnologiche e i governi a salvare la salute mentale dei più giovani, indicando alcune possibili strade. La più semplice: ritardare il più possibile l’utilizzo dello smartphone e proibire che venga usato a scuola. La generazione ansiosa si concentra sul problema dello sviluppo psicologico dei giovani nel mondo digitale. Forse, seguendo le sue indicazioni, li potremo ancora salvare. Ma chi salverà gli adulti?